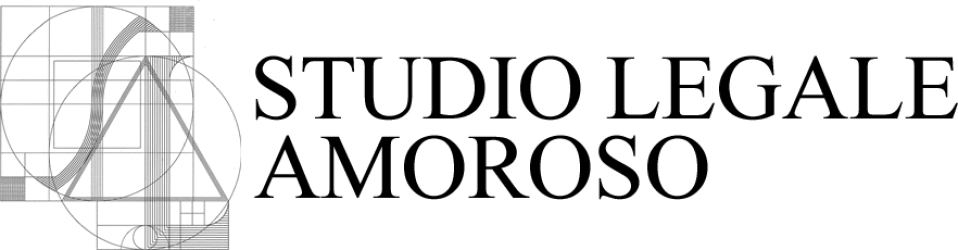Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal Sen. Silvio Berlusconi avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di appello di Milano ed annullata dalla Corte di cassazione limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea per anni 5 dai pubblici uffici, ed avverso la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, con la quale veniva determinata la stessa pena accessoria in anni 2, confermata dalla Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 16 novembre 2022, n. 43537 – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva secondo cui la violazione delle regole del giusto processo (da parte del giudice di legittimità) deve assumere anch’essa rilievo per l’instaurazione del giudizio di revisione – ha invece affermato il principio secondo cui l’accesso all’istituto della revisione è condizionato all’esistenza di un pregresso e definitivo accertamento della violazione stessa ad opera di una sentenza irrevocabile della Corte EDU, e la violazione dell’art. 6 CEDU non è immediatamente deducibile come motivo di revisione in mancanza di tale specifico accertamento.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 16 novembre 2022, n. 43537
| ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
| Conformi | Non si rinvengono precedenti in termini |
| Difformi | Non si rinvengono precedenti in termini |
Prima di soffermarci sulla pronuncia resa dalla Suprema Corte, deve essere ricordato che l’art. 630, c.p.p., sotto la rubrica «Casi di revisione», prevede che “1. La revisione può essere richiesta:
- a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
- b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;
- c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;
- d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato”.
Il tema posto dalla sentenza qui commentata ruota attorno al problema se la violazione delle regole del giusto processo (da parte del giudice di legittimità) debba assumere anch’essa rilievo per l’instaurazione del giudizio di revisione. In sostanza, si sosteneva da parte della difesa del Sen. Berlusconi che la scoperta di nuovi elementi possa e debba riguardare anche gli aspetti processuali allorquando si assumano violate le regole del giusto processo, come nel caso di processo celebrato in violazione del principio del giudice naturale o dell’imparzialità del giudice medesimo. E ciò a prescindere dall’accertamento di specifiche violazioni da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare come la revisione rientri tra i mezzi straordinari d’impugnazione le cui caratteristiche sono:
| a) di essere proponibile contro sentenze già passate in giudicato (ed in ciò risiede il primo connotato di eccezionalità);
b) di essere, proprio per la natura di rimedio straordinario, svincolata da qualsiasi termine. |
In merito alla possibilità di superare i limiti del giudicato attraverso la revisione, in ragione della violazione dedotta, si rileva quanto segue. Con la sentenza n. 501/2000 la Corte costituzionale, nell’escludere il contrasto dell’art. 627, commi 3 e 4 e 628, comma 2, del codice di procedura penale con gli artt. 3, comma 1, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, ha ricordato che “è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale — identificabile positivamente in quella della Cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione» — la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso“, ed ha sottolineato “che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione; sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell’art. 111 della Costituzione, come modificato dall’art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2″.
La stessa Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza n. 2/2022, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ha ribadito il principio della valenza costituzionale del giudicato, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha significativamente esteso in via pretoria l’ambito di applicazione dei rimedi che consentono di superare il giudicato stesso, ma sempre sul presupposto che gli sia sopravvenuto un “fatto” esterno: “ad esempio ammettendo la revoca di una condanna pronunciata sulla base di una disposizione penale giudicata incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di giustizia (Cass. pen. sez. I, sentenza 12/04/2012, n. 14276) ovvero di una condanna fondata su una norma incriminatrice già abrogata al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato (Cass. pen. sez. Unite, sentenza 23/6/2016, n. 26259), nonché la rideterminazione della pena nel caso di sopravvenienza di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dichiarativa di una violazione convenzionale relativa al quantum della pena inflitta (Cass. pen. sez. Unite, sentenza 07/05/2014, n. 18821) ovvero nel caso di sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della comminatoria edittale (Cass. pen., sez. Unite, sentenza 29/05/2014, n. 42858)”.
La stessa sentenza Corte cost. n. 2/2022, per contro, esclude che eventuali nullità processuali “interne” al giudizio, quand’anche assolute, possano esser fatte valere oltre il giudicato. Osserva, infatti, che in tal modo si introdurrebbe “nel sistema un’ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita che la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili»: le quali debbono sì essere rilevate, anche d’ufficio, «in ogni stato e grado del procedimento», ma non oltre – appunto – la sua definiva conclusione (sentenza Corte cost. n. 224/1996, che richiama la sentenza Corte cost. n. 294/1995)”, aggiungendo che “ciò spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità “resistenti al giudicato”, con le quali chi sia stato condannato in via definitiva potrebbe rimettere in discussione accertamenti già compiuti nei successivi gradi di giudizio sulla sussistenza di vizi procedimentali”.
Con riferimento alla violazione dell’art. 6 della CEDU la questione è stata esaminata dalla Corte costituzionale in due distinte occasioni, in ragione dell’obbligo dell’ordinamento interno di conformarsi alle pronunce della Corte EDU. Con la sentenza Corte cost. n. 129/2008, infatti, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Con la sentenza Corte cost. n. 113/2011 ha dichiarato, invece, l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ancorché incentrate sulla necessità di assicurare attuazione ai pronunciamenti della CEDU, le due sentenze offrono spunti motivazionali sicuramente rilevanti nell’affrontare le problematiche sollevate con la sentenza qui commentata. Con la sentenza Corte cost. n. 129/2008, la stessa Corte aveva già puntualizzato, infatti, che la revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di “fatti” nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) “non equo”, respingendo la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo cui per “fatto” – ai fini dell’applicazione dell’art. 630 c.p.p. – non dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all’origine della vicenda processuale, ma anche l’accertamento dell’invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un fatto da cui, comunque, dipende l’applicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte. Ha escluso nell’occasione la Corte che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di “fatto” anche l’ipotesi dell’accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si possa desumere dall’art. 187, comma 2, c.p.p.: una norma secondo la quale è “fatto” anche quello da cui dipende “l’applicazione di norme processuali”.
Ha osservato, infatti, la Corte che “la disposizione citata – nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali (per l’appunto) dipende l’applicazione delle norme processuali – si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto “materiale” che deve essere “provato”, perché si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del legittimo impedimento, che determina l’assoluta impossibilità di comparire; o l’evento che integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili. Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall’accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti ed alla relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a volta, in discorso”.
Conclude, dunque, la Corte rilevando che “ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della “correttezza”, formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente “il fatto nuovo” (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall’art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione“.
Tali concetti sono tutti ribaditi nella sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale, la quale ha riconosciuto che l’ipotesi della riapertura del processo collegata al vincolo scaturente dalla CEDU risulta eterogenea rispetto all’istituto della revisione e, tuttavia, “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa”, pur nella consapevolezza dei profili distonici evidenziati, ha ritenuto di dover individuare nell’art. 630 c.p.p. la sedes dell’intervento additivo richiesto, in quanto “comportando la revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, (…) costituisce l’istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell’ordinamento nazionale al parametro evocato”.
L’eterogeneità del rimedio della revisione per denunciare la lesione dei principi del giusto processo nella fase del giudizio viene in sostanza confermata dalla Corte costituzionale nella seconda sentenza, ma eccezionalmente superata solo in ragione di un fatto successivo e, cioè, di una pronuncia della Corte EDU e (soprattutto, n.d.r.) della improcrastinabile necessità di adeguare l’ordinamento interno all’art. 46 della Convenzione EDU, valorizzando al riguardo sul piano formale “l’assonanza” dello schema operativo della revisione.
Tanto premesso, nel caso in esame, ben si spiega l’approdo dei giudici di legittimità che, proprio facendo leva sulle due sentenze della Corte costituzionale richiamate, hanno ribadito che l’accesso all’istituto della revisione è condizionato all’esistenza di un pregresso e definitivo accertamento della violazione stessa ad opera di una sentenza irrevocabile della Corte EDU, e che la violazione dell’art. 6 CEDU non è immediatamente deducibile come motivo di revisione in mancanza di tale specifico accertamento.
Da qui, pertanto, il rigetto del ricorso.
Riferimenti normativi: